
Da Roma a Inizio medioevo – Secondo la tradizione, la città di Roma fu fondata il 21 aprile del 753 a.C. da Romolo sul colle palatino. In realtà , già in precedenza erano sorti villaggi in quella posizione, fondamentale per la via di commercio del sale, ma solo alla metà dell’VIII secolo questi si unirono in una sola città . La zona era dotata, inoltre, di un buon potenziale agricolo, e la presenza dell’isola Tiberina rendeva facile l’attraversamento del vicino fiume Tevere.
Romolo instaurò nella città il regime monarchico: fino al 509 a.C., Roma fu retta, secondo la tradizione, da sette re, che apportarono notevoli contributi allo sviluppo della società .
Ognuno dei primi quattro, infatti, operò in un diverso ambito dell’amministrazione statale”: il fondatore eponimo Romolo diede il via alla prima guerra di espansione contro i Sabini, originatasi dall’episodio del ratto delle Sabine, e associò al trono il re nemico Tito Tazio, allargando per primo le basi del neonato stato romano. Stabilì poi la suddivisione della popolazione in tre tribù e pose le basi per la ripartizione tra patrizi e plebei.
Il suo successore Numa Pompilio istituì i primi collegi sacerdotali, come quello delle Vestali, e riformò il calendario. In seguito, Tullo Ostilio riprese le ostilità contro i popoli vicini e sconfisse la città di Alba Longa, mentre il successore Anco Marzio operò nel campo dell’urbanistica: costruì il primo ponte di legno sul Tevere, fortificò il Gianicolo e fondò il porto di Ostia.
Ai primi quattro re, di origine latina, fecero seguito altri tre di origine etrusca: verso la fine del VII secolo, infatti, gli Etruschi, all’apogeo della loro potenza, estesero la loro influenza anche su Roma, che stava divenendo sempre più grande e la cui importanza a livello economico iniziava a farsi considerevole.
Era dunque fondamentale per gli etruschi assicurarsi il controllo su una zona che assicurava il passaggio delle rotte commerciali; comunque non si ebbe mai un reale controllo militare etrusco su Roma. Il primo re etrusco, Tarquinio Prisco, combatté contro i popoli confinanti, ordinò la realizzazione di numerose opere pubbliche, tra cui il Circo Massimo, la Cloaca Massima e il tempio di Giove Capitolino sul Campidoglio e apportò, infine, anche alcuni cambiamenti in campo culturale.
Il suo successore, Servio Tullio, fu, secondo la leggenda, colui che ideò l’ordinamento centuriato, sostituendolo alla precedente ripartizione della popolazione; combatté anch’egli contro alcune delle principali città etrusche e latine limitrofe a Roma. Ultimo monarca a governare Roma fu Tarquinio il Superbo che fu allontanato dall’Urbe nel 510 a.C., secondo la leggenda con l’accusa di aver commesso violenze nei confronti della giovane Lucrezia; il patriziato romano, comunque, non era più disposto a sottostare al potere centralizzato del re, ma desiderava acquisire un’influenza, in campo politico, pari a quella che già rivestiva negli altri ambiti della vita civile.
Dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo ed il fallimento (determinato, secondo la leggenda, dalle eroiche azioni di Muzio Scevola, Orazio Coclite e Clelia) del suo tentativo di riprendere il potere con l’aiuto degli Etruschi condotti dal lucumone di Chiusi, Porsenna, fu instaurata, ad opera di Lucio Giunio Bruto, organizzatore della rivolta antimonarchica, la forma di governo della Repubblica.
Essa prevedeva la spartizione tra più cariche dei poteri che prima erano appartenuti ad un uomo solo, il re: il potere legislativo fu assegnato alle assemblee dei comizi centuriati e del senato, e furono create numerose magistrature, consolato, censura, pretura, questura, edilità , che gestissero i vari ambiti dell’amministrazione. Tutte le cariche, alcune delle quali erano cum imperio, erano collegiali, in modo tale che si evitasse l’affermazione di singoli uomini che potessero accentrare il potere nelle loro mani.
Roma si trovò subito a lottare contro le popolazioni latine delle zone limitrofe, sconfiggendole nel 499 a.C.[6] nella battaglia del lago Regillo, e federandole a sé nella Lega Latina mediante la firma del foedus Cassianum, nel 493 a.C. Combatté poi contro gli Equi e i Volsci, e, una volta sconfitti, si scontrò con la città etrusca di Veio, che fu espugnata da Marco Furio Camillo nel 396 a.C.
I primi anni di vita della Repubblica Romana furono notevolmente travagliati anche nell’ambito della politica interna, in quanto le gravi disuguaglianze sociali che avevano portato alla caduta del regno non erano state cancellate. I plebei iniziarono così una serie di proteste contro la classe dominante dei patrizi: nel 494 a.C., infine, si ritirarono in secessione sul colle Aventino.
La situazione si risolse con l’istituzione della magistratura del tribunato della plebe e con il riconoscimento del valore legale delle assemblee popolari. Importanti acquisizioni furono anche la redazione, nel 450 a.C. da parte dei decemviri, delle leggi delle Dodici Tavole, che garantivano una maggiore equità in ambito giudiziario, l’approvazione della lex Canuleia, nel 445 a.C.
Nel 386 a.C., l’esercito romano fu sconfitto dai Galli guidati da Brenno, che penetrarono nell’Urbe e la sottoposero ad un rovinoso saccheggio.Vent’anni dopo, nel 367 a.C., furono promulgate le leges Liciniae Sextiae, che costituivano un’ulteriore acquisizione di diritti da parte della plebe.
Ormai potenza egemone nell’Italia centrale, Roma cominciò a meditare un’espansione verso Sud; per premunirsi, inoltre, da eventuali defezioni degli alleati latini, stipulò nel 354 a.C. un’alleanza con i Sanniti, contro i quali, tuttavia, combatté pochi anni più tardi, in difesa della città di Capua. Il conflitto, apertosi nel 343 a.C., terminò nel 341 a.C. senza alcun sostanziale mutamento dello status quo.
Tra il 340 e il 338 a.C., inoltre, Roma fu costretta a combattere una nuova e sanguinosa guerra contro i Latini, e ottenne la vittoria solo con grandissimi sforzi. Nel 327 a.C., poi, si riaprì il conflitto con i Sanniti: i Romani, dopo le sconfitte delle Forche Caudine e di Lautula e, riuscirono a volgere la situazione in loro favore, riportando una complessiva vittoria nel 304 a.C. Contro i Sanniti Roma combatté, infine, una terza guerra tra il 298 e il 290 a.C., al termine della quale ogni resistenza poteva dirsi annientata.
Consolidata la propria egemonia sull’Italia centro-meridionale, Roma arrivò a scontrarsi con le città della Magna Grecia e con la potente Taranto: con il pretesto di soccorrere la città di Turi, minacciata, Roma violò intenzionalemente un patto stipulato con Taranto nel 303 a.C., scatenando la guerra. Taranto invocò allora l’aiuto del re d’Epiro Pirro, che giunse in Italia nel 280 a.C. portando con sé un esercito composto anche da numerosi elefanti.
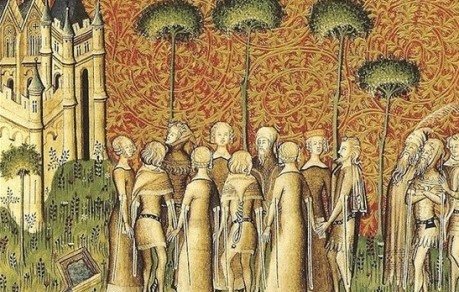
L’epirota riuscì a sconfiggere i Romani a Heraclea e ad Ascoli, seppure a costo di gravissime perdite; decise dunque di consolidare il suo potere sul Sud dell’Italia, ma ottenne una sostanziale sconfitta in Sicilia, dove le colonie greche, preoccupate per le tendenze dispotiche di Pirro, si allearono con Cartagine e riuscirono a respingere l’invasore. L’epirota marciò dunque contro i Romani che, riorganizzatisi, erano tornati a minacciare Taranto, ma fu duramente sconfitto a Maleventum nel 275 a.C. e costretto a tornare oltre l’Adriatico. Taranto, dunque, fu nuovamente assediata e costretta alla resa nel 272 a.C.: Roma era così potenza egemone nell’Italia peninsulare, a sud dell’Appennino Ligure e Tosco-Emiliano.
Nel 264 a.C. Roma inviò un piccolo contingente in soccorso di Messina, con l’intento di assicurarsi il controllo dello stretto, fondamentale per il transito delle navi: i Cartaginesi, dunque, che ambivano anch’essi al controllo dell’isola, decisero di reagire con la guerra. Dopo una prima fase di scontri terrestri, in cui riuscì ad ottenere alcune vittorie, Roma decise di sfidare i Cartaginesi sul mare, e, approntata una flotta di navi dotate di corvi, sconfisse i nemici nella battaglia di Milazzo.
Nel tentativo di infliggere una decisiva sconfitta a Cartagine, Roma affidò al console Marco Atilio Regolo l’incarico di portare la guerra in suolo africano: sconfitta nuovamente la flotta nemica a Capo Ecnomo, il generale riuscì a sbarcare in Africa ma, dopo alcune vittorie iniziali, fu pesantemente sconfitto e costretto alla resa. Nel 241 a.C., dunque, Roma, approntata una nuova flotta guidata da Gaio Lutazio Catulo, sconfisse nuovamente i Cartaginesi preso le Isole Egadi: sottratto ai nemici il predominio sul mare i Romani poterono concludere anche le operazioni terrestri, espandendo il loro controllo su tutta la Sicilia, e costringendo Cartagine alla resa.
Allontanato provvisoriamente il pericolo cartaginese, Roma si preoccupò di consolidare il proprio dominio riducendo la Sicilia in condizione di provincia e di estenderlo annettendo la Sardegna e la Corsica; sconfisse inoltre i pirati illirici che, tacitamente supportati dalla regina Teuta, infestavano le coste adriatiche e respinse un nuovo assalto dei Galli a Nord. Preoccupato dalla nuova espansione cartaginese nella penisola iberica, intanto, il Senato stipulò un nuovo patto con la potenza africana; quando tuttavia nel 218 a.C.
Il generale punico Annibale Barca attaccò la città di Sagunto, alleata di Roma, si decise di dichiarare nuovamente guerra a Cartagine. Annibale, allora, portando con sé un solido esercito e alcuni elefanti, valicò le Alpi e attaccò Roma da Nord, sconfiggendo le legioni presso il Ticino, la Trebbia e il Trasimeno. Dopo una fase di stallo, durante la quale Roma poté riorganizzarsi, dovuta alla politica attuata dal dictator Quinto Fabio Massimo, soprannominato Cunctator (temporeggiatore), le legioni romane al comando dei consoli Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone marciarono nel 216 a.C. contro Annibale a Canne, ma furono duramente sconfitte.
Mentre numerose città si alleavano con i Cartaginesi e anche la Macedonia di Filippo V scendeva in guerra contro Roma, Annibale si attardò nel Sud Italia, mentre i Romani, seppure provati, poterono lentamente ricostituire le proprie forze: il console Publio Cornelio Scipione riuscì a sconfiggere ripetutamente i Cartaginesi in Spagna. In Italia i consoli Marco Livio Salinatore e Gaio Claudio Nerone sconfissero e uccisero il fratello di Annibale, Asdrubale, presso il Metauro, mentre si apprestava a portare rinforzi alle forze puniche in Italia.
Contemporaneamente Roma otteneva numerose vittorie anche sul suolo italico, riconquistando le città che avevano defezionato per allearsi con Annibale. Stremato da un decennio di guerra e vistosi negare i rinforzi dalla madrepatria, lo stesso Annibale fu costretto a fare ritorno in Africa nel 203 a.C., dopo che Scipione, conquistata la Penisola Iberica e ristabilita la situazione in Italia era sbarcato nel territorio nemico per tentare di ottenere una vittoria definitiva. I due generali si scontrarono nel 202 a.C. a Zama, e l’esercito romano ottenne una sofferta ma decisiva vittoria. Cartagine, dunque, minacciata da vicino dalle forze nemiche, fu costretta a capitolare e ad accettare le condizioni di pace imposte da Roma.
Ormai potenza egemone del Mediterraneo occidentale, Roma poté presto dimostrare le sue mire espansionistiche a danno degli stati ellenistici dell’Oriente: nel 200 a.C., gli abitanti di Rodi e Pergamo inviarono a Roma, sentendosi minacciati dalla Macedonia di Filippo V, una richiesta di aiuto, e l’Urbe, inviato a sua volta un ultimatum a Filippo, decise di intervenire. Nel 197 a.C. il console Tito Quinzio Flaminino inflisse alle truppe macedoni una sconfitta definitiva presso Cinocefale, ed un anno più tardi proclamò ufficialmente la liberazione della Grecia dall’egemonia macedone.
I Greci, tuttavia, consci di dover respingere i Romani per non essere annessi al loro stato, preferirono allearsi con il sovrano sele ucide Antioco III: Roma, dunque, nel 191 a.C., dichiarò guerra ad Antioco, e, dopo averlo sconfitto presso le Termopili nel 191 a.C. e presso Magnesia nel 188 a.C., lo costrinse a firmare una pace con cui cedeva a Roma alcune terre in Asia Minore.
Nel 171 a.C., il figlio di Filippo di Macedonia, Perseo, si sollevò nuovamente in armi contro i Romani, dando inizio alla terza guerra macedonica. Dopo alterne vicende, nel 168 a.C. l’esercito romano guidato da Lucio Emilio Paolo sconfisse duramente la truppe di Perseo a Pidna, e Roma poté dividere il territorio macedone tra quattro repubbliche subalterne e tributarie.
Cartagine, intanto, fortemente provata dalle conseguenze della seconda guerra punica, era sottoposta ai continui attacchi del re numida Massinissa, alleato dei Romani, che approfittava della situazione per estendere sempre di più i propri possedimenti ai danni della stessa Cartagine.
A Roma, dunque, giunsero ambasciatori dalla città africana, ma l’Urbe rifiutò di intervenire per mantenere la pace; nel 50 a.C. Cartagine fu dunque costretta a violare gli accordi di pace e a reagire con la forza a Massinissa. Il senato, quindi, sobillato da Catone il Censore, decise di attaccare Cartagine, e nel 147 a.C. si risolse ad inviare in Africa il console Publio Cornelio Scipione Emiliano: questi, dopo un lungo assedio, nel 146 a.C. espugnò e rase al suolo la città .
Contemporaneamente, nel 150 a.C. un tale Andrisco, sostenendo di essere figlio di Perseo, guidò una nuova rivolta di Greci e Macedoni contro Roma: dopo alcuni iniziali successi, tuttavia, le forze ribelli furono duramente sconfitte. Nel 146 a.C., infine, i Romani rasero al suolo Corinto. Con la sconfitta dei nemici contro cui combatteva da anni su entrambi i fronti, Roma era diventata padrona del Mediterraneo.
Le nuove conquiste, tuttavia, portarono anche notevoli cambiamenti nella società romana: i contatti con la cultura ellenistica, temuta e osteggiata dallo stesso Catone, modificarono profondamente gli usi che fino ad allora si rifacevano al mos maiorum, trasformando radicalmente la società dell’Urbe.
Gli immensi territori che la Repubblica Romana aveva conquistato ebbero una serie di nefaste conseguenze per essa stessa e per l’Italia: in primis, l’enorme numero di schiavi che vi affluì, fece sì che questi soppiantassero del tutto i lavoratori, grazie al loro basso costo, dando via al fenomeno che vedeva i coltivatori diretti sempre più assorbiti dai latifondisti, con conseguenze devastanti sul piano economico e produttivo.
A tentare una riforma che ponesse un rimedio alla crisi fu, per primo, Tiberio Sempronio Gracco, che emanò una legge che limitava l’occupazione delle terre dello stato a 125 ettari e riassegnava le terre eccedenti ai contadini in rovina: una famiglia nobile poteva avere 500 iugeri di terreno, più 250 per ogni figlio, ma non più di 1000; i terreni confiscati furono distribuiti in modo che ogni famiglia della plebe contadina avesse 30 iugeri (7,5 ettari).
Colpendo in questo modo gli interessi delle classi aristocratiche, finì assassinato ma il Senato Romano non revocò le sue leggi, che comunque diedero qualche iniziale risultato. La riforma fu poi continuata dal fratello, Gaio Sempronio Gracco, che finì suicida braccato dagli stessi sicari del fratello.
Dopo la morte dei due fratelli Gracchi, il malcontento del popolo nei confronti dell’aristocrazia si fece più forte. Ad alimentarla si mise sia lo scandalo d’Africa del 112 a.C., che le elezioni consolari del 109 a.C., alle quali Gaio Mario, un popolare, si presentò con forti possibilità di vincere. Quinto Cecilio Metello Numidico, console precedente, si oppose a questa candidatura, sebbene Gaio Mario fosse un suo luogotenente nelle Guerre contro Giugurta solo perché questi non era di origine aristocratica. L’Assemblea si schierò dunque compatta con il candidato popolare, che così vinse facilmente.
Mario, una volta eletto, reclamò il posto di Quinto Cecilio Metello Numidico nella guerra giugurtina, e la guerra si concluse in pochi mesi, con il trionfo di Gaio Mario. Per sei anni, l’Assemblea gli confermò il mandato da console, durante i quali Mario si trovò a fronteggiare diverse minacce, in primis quella dei Cimbri e dei Teutoni, massacrati nella Aquae Sextiae ed in quella dei Campi Raudii, vicino Vercelli. Gaio Mario varò quindi una riforma dell’esercito, che da “esercito nazionale” divenne “esercito mercenario”, poiché non fu più composto dai cittadini, ma da nullatenenti e disperati, che venivano regolarmente pagati e a cui venivano assegnate terre dopo ogni vittoria.
Ma nella politica, Gaio Mario ebbe meno fortuna: alleatosi con Lucio Appuleio Saturnino, tribuno della plebe, e con Gaio Servilio Glaucia, pretore, scoprì ben presto che la politica romana era troppo marcia: i due alleati, infatti, proposero ed ottennero di abbassare ancora il calmiere del grano, che mise in pericolo il bilancio dello Stato. Gaio Mario, così, fu costretto a liquidare i suoi amici, schierandosi con i conservatori. Il bagno di sangue che seguì lo rese impopolare ad entrambi gli schieramenti, e così si ritirò dalla vita politica, partendo per l’Oriente.
Nel 91 a.C. fu eletto tribuno della plebe Marco Livio Druso, che propose tre riforme per salvare lo stato dalla crisi: distribuire nuove terre fra i poveri; ridare il monopolio nelle giurie al Senato Romano, dopo avervi aggiunto altri 300 membri; conferire la cittadinanza romana a tutti gli abitanti della provincia d’Italia. L’Assemblea approvò i primi due punti, ma non il terzo, che costò a Marco Livio Druso la vita: fu assassinato mentre spiegava i motivi della sua proposta.
Scoppiò così la guerra sociale: dopo secoli di unione a Roma, la provincia d’Italia non ci stava ad essere trattata ancora come una semplice provincia conquistata. La mancanza di rappresentanti in Senato e le due leggi, del 126 a.C. e del 95 a.C., che rispettivamente impediva agli italiani di provincia di emigrare a Roma e scacciava quelli che vi erano già , fecero il resto. Salvo in Etruria ed Umbria, la ribellione fu totale, ed ai cittadini si unirono anche gli schiavi, che fondarono una repubblica federale con capitale a Corfinium.
Roma chiamò Gaio Mario per fronteggiare l’ennesima guerra: questi reclutò un suo esercito e massacrò i ribelli, causando 300.000 morti. La pace che seguì fu quella di un cimitero: il Senato Romano propose la pace offrendo la cittadinanza romana ai ribelli ed agli abitanti di Etruria ed Umbria, come premio di fedeltà . I ribelli accettarono e la guerra sociale si concluse.
Lucio Cornelio Silla fu eletto console nell’88 a.C., poco dopo la fine della guerra sociale. Già noto al popolo ai tempi delle guerre contro Giugurta, e di quelle contro i Teutoni ed i Cimbri, durante le quali era stato luogotenente di Gaio Mario, aveva iniziato il proprio cursus honorum nel 99 a.C..
Nominato console, mentre stava per partire alla volta delle Guerre mitridatiche in Asia Minore, gli giunse la notizia che Gaio Mario stava per sostituirlo alla guida dell’esercito. Così corse a Nola, radunò l’esercito e lo portò a Roma, dove sconfisse Gaio Mario, che scappò nella provincia d’Africa.
Silla si nominò proconsole (che gli dava il controllo dell’esercito), fece eleggere due nuovi consoli (Gneo Ottavio e Lucio Cornelio Cinna), e finalmente partì per la provincia d’Asia.
Appena partito Lucio Cornelio Silla, i due consoli erano già alle armi: i conservatori (optimates) capeggiati da Gneo Ottavio ed i democratici (populares) da Lucio Cornelio Cinna. Era la guerra civile.
La situazione non migliorò con la morte di Gaio Mario, che fu sostituito da Lucio Valerio Flacco. Assieme a Lucio Cornelio Cinna continuarono a spargere il terrore, finché Lucio Valerio Flacco non fu mandato in Oriente a deporre Lucio Cornelio Silla. Ma quando i due s’incontrarono, Silla riuscì a convincere Lucio Valerio Flacco a schierarsi con lui. Nell’83 a.C. arrivarono a Brindisium, e, contemporaneamente, a Roma, Lucio Cornelio Cinna fu ucciso dalla popolazione in rivolta.
Gaio Mario il Giovane, figlio di Gaio Mario, radunò un esercito tra i conservatori e si preparò allo scontro frontale: nella Battaglia di Porta Collina, oltre 50.000 uomini nelle schiera di Gaio Mario il Giovane furono uccisi ed altri furono imprigionati. La guerra civile era finita. Era il 27 gennaio dell’81 a.C..
Lucio Cornelio Silla divenne così dictator, e lo restò per 2 anni, durante i quali lasciò il segno in diversi modi:
inventò il culto della personalità , facendo coniare monete con la sua effigie ed introducendo nel calendario la festa della sua vittoria:
trattò Roma da semplice città conquistata, facendola presidiare da un esercito;
represse ogni forma di dissenso, uccidendo 40 senatori e 2600 cavalieri che avevano simpatie per Gaio Mario. Tra i proscritti c’era anche un giovane di nome Caio Giulio Cesare, nipote di Gaio Mario, che si salvò grazie all’aiuto di amici in comune con una semplice condanna al confino;
estese la cittadinanza romana a tutti gli italiani, ed a molti Galli ed Iberi;
distribuì terre ai veterani del suo esercito;
abolì le distribuzioni gratuite di grano;
ristabilì la regola dei dieci anni di intervallo per chi concorreva al consolato per la seconda volta.
congedò l’esercito ed emanò una legge che vietasse a qualunque esercito di sostare in Italia.
Compiute queste riforme, decise, tra lo sbigottimento generale, di lasciare ogni carica e di ritirarsi a vita privata nella sua villa di Cuma. Quello stesso giorno, tornato ad essere un semplice cittadino, un Pochi anni dopo la morte di Silla, la situazione politica romana precipitò di nuovo nel caos: prima la ribellione della Spagna, che fu domata da Pompeo, poi la ben più grave rivolta degli schiavi, capeggiata da Spartaco.
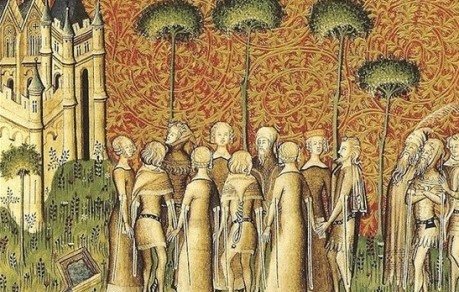
Nel 73 a.C., infatti, un gruppo di quasi cento schiavi della scuola di Lentulo Batiato di Capua, si ribellarono e fuggirono. Nominato loro capo Spartaco, un gladiatore tracio, chiamarono nelle loro fila qualunque schiavo desideroso di libertà , ed in poco tempo il loro esercito arrivò a contarne settantamila.
Le prime battaglie sorrisero agli insorti, che batterono gli eserciti romani e mossero verso le Alpi. Persero una battaglia, ne vinsero un’altra, e si trovarono d’improvviso alle porte di Roma. Il Senato Romano mandò allora contro i ribelli un esercito guidato da Crasso e composto dal fiore dell’aristocrazia romana, mentre dalla Spagna stava ritornando Pompeo: Spartaco preferì così affrontare apertamente l’esercito romano, e fu sconfitto in via definitiva, morendo in battaglia. I ribelli catturati vivi furono crocifissi lungo la Via Appia.
Di lì a poco, parve che la democrazia fosse tornata dopo la restaurazione di Silla. Ma poco dopo la partenza di Pompeo, emerse la possibile minaccia di Lucio Sergio Catilina. Questi era un aristocratico che si era schierato apertamente coi popolari, con un programma radicale, che prevedeva tra le altre cose, l’annullamento dei debiti per tutti i cittadini.
Catilina si presentò alle elezioni, ma perse. Radunò così a Fiesole un migliaio di seguaci, con i quali si presentò l’anno dopo nuovamente alle elezioni. Ma ancora una volta fu battuto da Cicerone, che lo accusò di aver organizzato un complotto per ucciderlo.
Il 7 novembre del 63 a.C. davanti al Senato Romano, Cicerone pronunciò il suo famoso discorso (le Catilinarie) che durò per tre giorni. Il 3 dicembre fu emesso un mandato d’arresto per Lentulo, Cetego ed altri presunti cospiratori, che il 5 dicembre furono giustiziati. L’unica voce del Senato che difendeva i sentenziati era quella di un giovane di nome Caio Giulio Cesare. Alla fine della requisitoria, alcuni senatori tentarono di ucciderlo, ma Cesare riuscì a fuggire. Cicerone fece così eseguire la sentenza, mentre Caio Antonio, l’altro console, partì con un esercito contro Catilina.
Nella battaglia di Pistoia, che si combatté nel gennaio del 62 a.C., i sostenitori di Catilina si batterono con coraggio, ma furono sterminati. Lo stesso Catilina perse la vita.
Caio Giulio Cesare, nipote di Mario, aveva già fatto carriera negli anni tumultuosi seguiti alla dittatura di Silla, ed era scampato ad un paio di agguati, come quello avvenuto mentre difendeva Catilina.
Quando Pompeo si trovò in contrasto con il Senato romano, Cesare ebbe la prontezza di proporgli il primo triumvirato: Pompeo avrebbe finanziato l’impresa, Crasso avrebbe prestato la sua influenza sulle classi ricche dell’alta borghesia, ed infine Cesare avrebbe fatto da garante per il popolo. L’aristocrazia fu tagliata così fuori dal potere.
Cesare vince così facilmente le elezioni a console romano, mentre per l’aristocrazia salì Marco Calpurnio Bibulo. Cesare mantenne i suoi impegni: distribuì terre ai soldati di Pompeo (che era stato uno dei motivi di contrasto col Senato romano), e ne ratificò gli impegni in Oriente. Poi varò tutte le leggi proposte dai Gracchi, che ci avevano rimesso la vita. Inventò il primo quotidiano, chiamato Acta Diurna, in cui tutte le decisioni del Senato venivano spiegate, motivate e commentate. Essendo gratuito, ed affisso sui muri della città , il Senato romano si ritrovò così a dover dare conto all’intera popolazione delle sue scelte.
Dopo una serie di matrimoni combinati con gentes influenti della politica romana, Cesare, poco prima della scadenza del mandato, si fece nominare proconsole della Gallia Cisalpina e Narbonense: questo incarico gli conferì così il comando delle truppe a nord dell’Italia (la legge vietava che ce ne fossero a sud del Rubicone), rendendolo il padrone del paese.
Con le sue truppe a guardia dell’Italia, l’elezione a consoli di Aulo Gabinio e Lucio Calpurnio Pisone Cesonino (che gli dovevano l’appoggio) e di Publio Clodio Pulcro a tribuno della plebe (che gli doveva un’assoluzione), l’appoggio di Pompeo, i denari di Crasso, ed il Senato sotto controllo, Caio Giulio Cesare si dedicò così alla conquista della Gallia.
Cesare intervenne in Gallia chiamato a difenderla dalle stesse tribù alla vigilia di un’invasione di Elvezi e di Germani. Cercata e non trovata una soluzione diplomatica con Ariovisto, capo dei Germani, Cesare li affrontò in due battaglie campali: prima furono sbaragliati gli Elvezi, che tornarono in Rezia ed accettarono il vassallaggio a Roma; poi toccò ai Germani, che furono annientati ad Ostheim.
Cesare chiese così alla Gallia di accettare la sua protezione da future invasioni, ma le tribù rifiutarono, chiamando in aiuto i Belgi: questi furono a loro volta sterminati, e Cesare proclamò, prematuramente, la Gallia conquistata. Seguì una nuova invasione di Germani, ancora una volta annientati, ed una piccola spedizione di Cesare in Britannia, da cui però dovette ritornare per la rivolta delle tribù galliche, che per la prima volta si erano riunite sotto il comando di un solo uomo: Vercingetorige.
Dopo una serie di battaglie minori, Cesare si ritrovò circondato e ricorse alla mossa più audace: assediare Alesia, la città dove Vercingetorige aveva radunato l’esercito. Dopo sette giorni di assedio, senza ricevere rifornimenti (i 240.000 galli che erano arrivati furono respinti dalle legioni), Vercingetorige chiese la resa.
Mentre Cesare conquistava la Gallia, Roma agonizzava: Crasso era stato ucciso a Carre, durante la guerra coi Parti che egli stesso aveva mosso; Pompeo non si mosse ed anzi sembrò voler approfittare dell’occasione che gli fornirono l’assassinio di Publio Clodio Pulcro, tribuno della plebe in carica per conquistare il potere.
Questi, infatti, era stato ucciso, e Pompeo fece presidiare dal suo esercito la città . Catturato e giustiziato l’assassino, l’esercito rimase a presidio dei punti strategici di Roma, condizione che lo rendeva unico padrone dell’Urbe. Subito dopo, Pompeo fece ripristinare la condizione di essere presenti in città per potersi candidare a console, che di fatto escludeva Cesare, il cui mandato scadeva il 1 marzo di quell’anno, il 49 a.C., dalle elezioni, che si trovava ancora in Gallia.
Cesare si trovò a scegliere tra due soluzioni: o sciogliere l’esercito e consegnarsi alla Repubblica, che lo voleva evidentemente morto, oppure marciare in armi fino a Roma per scacciare Pompeo ma ritrovandosi ad essere un pericoloso criminale (perché la legge non permetteva agli eserciti di bivaccare in territorio italiano).
Il 10 gennaio del 49 a.C. fu presa la decisione di varcare il Rubicone (che segnava il confine tra la Gallia Cisalpina e l’Italia), e quindi di marciare in armi verso Roma. La sua marcia fu incruenta: i volontari affluivano nel suo esercito da ogni città , ed il 16 marzo arrivò nella capitale, lasciando l’esercito fuori le sue mura.
Pompeo era intanto fuggito nell’Epiro, dove stava allestendo un esercito, mentre i suoi alleati occupavano le province di Spagna e d’Africa. Cesare attaccò prima gli alleati in Spagna, che furono abilmente battuti, poi puntò sull’Epiro, dove lo attendeva Pompeo, che fu annientato nella battaglia di Farsalo e fuggì in Egitto, per tentare un’ultima disperata resistenza.
Tolomeo XIII, il re d’Egitto vassallo di Roma, per ingraziarsi Cesare, uccise a tradimento Pompeo, che cercava rifugio in quella provincia. Cesare si recò subito in Egitto per recuperare il corpo di Pompeo, ma qui rimase coinvolto in un intrigo amoroso con la moglie e sorella di Tolomeo XIII, la regina Cleopatra VII. I malumori degli egizi e di parte dei soldati romani sfociarono in una rivolta, che Cesare riuscì a domare. Restò poi nove mesi in Egitto, dopo i quali Cleopatra VII diede alla luce un figlio: Cesarione.
Cesare quindi decise di ripartire per l’Italia: prima si recò in Asia Minore per combattere una ribellione di Farnace II, figlio di Mitridate VI, che fu annientata nella battaglia di Zela, poi sbarcò a Taranto con Cleopatra, il neonato Cesarione ed i suoi fedeli soldati.
Dall’Italia partì per Thapsus, nella provincia d’Africa, per combattere gli ultimi irriducibili seguaci di Pompeo. Sbarcò nell’aprile del 46 a.C. e vi trovò ad aspettarlo 80.000 uomini, comandati da Quinto Metello Scipione, Marco Porcio Catone Uticense, Tito Labieno e Giuba I, re di Numidia. Il 6 febbraio del 46 a.C. si ebbe così la battaglia di Tapso, che fu tremenda, e dove trovarono la morte quasi tutto l’esercito repubblicano ed i suoi comandanti. Solo Tito Labieno riuscì a scappare in Spagna, dove fu raggiunto e definitivamente sconfitto nella battaglia di Munda il 17 marzo del 45 a.C. assieme ai suoi sostenitori.
Rientrato a Roma da trionfatore, fu nominato dictator a vita, e poté così iniziare la sua gigantesca opera riformista. I principali punti furono l’estensione della cittadinanza romana a tutti gli italiani ed una radicale riforma dei quadri della burocrazia e dell’esercito. Cercò, inoltre, di riempire i vuoti causati dalle guerre con nuovi elementi della borghesia rurale. Perdonò diversi alleati di Gneo Pompeo Magno, ed anzi li promosse a governatori di province. Ma preparava anche altre guerre: la vendetta contro i Parti, che avevano ucciso Crasso e la conquista della Germania Magna e della Scizia.
Tutti questi piani di guerra erano ancora in corso, quando il 15 febbraio del 44 a.C. fu assassinato da un gruppo di congiurati capitanati da Marco Giunio Bruto e Gaio Cassio Longino, che vedevano nelle loro fila anche Gaio Trebonio, Decimo Giunio Bruto Albino, Lucio Minucio Basilo e Servio Sulpicio Galba. I malumori repubblicani, infatti, non si erano ancora sopiti, ed i seguaci della Repubblica Romana vedevano in Cesare un aspirante re e credettero, eliminandolo, di restituire la sovranità al Senato e la libertà al popolo .
In realtà , i congiurati ottennero l’esatto opposto: il popolo era nettamente dalla parte di Cesare, e già il 18 marzo, quando si tennero i solenni funerali, i congiurati capirono che era meglio fuggire. All’apertura del testamento, si scoprì che Cesare aveva disposto la divisione del suo patrimonio (100 milioni di sesterzi) tra tutti i cittadini, mentre al municipium andavano i suoi beni immobili. Il resto era da dividere tra i tre nipoti, tra cui Caio Ottavio, nominato suo erede e perciò chiamato “Caio Giulio Cesare Ottaviano”.
Marco Antonio, fidato luogotenente di Cesare, che era stato trattenuto con l’inganno fuori dal Senato il giorno della congiura per evitare potesse difendere l’amico, ne rimase deluso, e mandò sia Marco Giunio Bruto che Gaio Cassio Longino a governare due province lontane per sottrarli alla folla. Rimasto da solo, cercò di diventare il successore di Cesare, ma doveva così scontrarsi con Ottaviano, che saputo di essere erede stava rientrando dall’Apollonia, dove si trovava al momento dell’assassinio dello zio.
Ottaviano, appena rientrato dai Balcani, chiese a Marco Antonio di rispettare il testamento di Cesare e quindi di distribuire il tesoro ai cittadini; al rifiuto, si fece prestare i soldi necessari dagli amici dello zio e poté provvedere di persona. Marco Antonio diffuse quindi la notizia di un complotto del giovane contro di lui, ed armò due legioni per catturarlo. Il Senato si schierò con Ottaviano, il quale affrontò le legioni nemiche a Modena, sbaragliandole. Marco Antonio fuggì, ed Ottaviano tornò a Roma da eroe.
Si proclamò quindi console ed annullò l’amnistia ai congiurati che avevano ucciso Cesare, decretandone la condanna a morte. Infine, invitò Marco Antonio far parte del Secondo triumvirato, aggiungendo anche Marco Emilio Lepido, che ne sarebbe stato il garante per la neutralità .
Nel 476 il re degli Eruli Odoacre, ultimo di una lunga schiera di condottieri germanici che nel periodo di decadenza dell’Impero romano d’Occidente avevano condotto le proprie orde in territorio italico, depose l’ultimo imperatore d’occidente, Romolo Augusto. Convenzionalmente, la data del 476 segna il passaggio dall’Antichità al Medioevo.
Inizialmente appoggiato dall’imperatore d’Oriente Zenone, che lo aveva insignito del titolo di dux Italiae (“duca d’Italia”) per indicarlo – almeno formalmente – come suo rappresentante, Odoacre presto si proclamò, per la prima volta nella storia, rex Italiae (“re d’Italia”). Nel 489 Zenone invitò gli Ostrogoti, altro popolo germanico allora stanziato nel bacino del basso Danubio, a intervenire in Italia per scacciarne Odoacre, allentando in questo modo la pressione che esercitavano sulla sua stessa capitale, Costantinopoli. Gli Ostrogoti, guidati da Teodorico, sconfissero definitivamente Odoacre nel 493.
Teodorico proseguì in gran parte la politica del suo predecessore e avversario, assegnando ai suoi Ostrogoti i compiti di sicurezza e di difesa e delegando ai Latini (o Romanici) le funzioni amministrative. Tra i collaboratori latini del sovrano si contarono anche i grandi intellettuali Cassiodoro e Boezio, anche se quest’ultimo cadde in seguito in disgrazia, venne imprigionato e fu infine ucciso.
La struttura latifondista della società e dell’economia italiana fu sostanzialmente preservata; la nuova ripartizione delle terre introdotta da Teodorico assegnò un terzo dei fondi ai conquistatori e i due terzi agli antichi abitanti. Durante il regno del sovrano germanico furono costruite nuove opere pubbliche, come il Mausoleo di Teodorico a Ravenna, e cercò, almeno nei primi anni, di mantenere pacifici i rapporti tra la maggioritaria Chiesa cattolica e gli aderenti al cristianesimo ariano, tra i quali si contava la maggior parte degli Ostrogoti e lo stesso re.
Alla morte di Teodorico (526) il trono passò al giovane nipote Atalarico, sotto la reggenza della madre Amalasunta, e in seguito al secondo marito della regina madre, Teodato (a sua volta nipote di Teodorico). Amalasunta perseguì una politica apertamente favorevole al cattolicesimo, che determinò una frattura tra il potere regio e la nobiltà gotica; la divisione favorì i progetti di riconquista dell’Italia del nuovo imperatore d’Oriente (ormai “imperatore bizantino”), Giustiniano, che nel 535 lanciò l’armata del generale Belisario contro gli Ostrogoti.
La riconquista giustinianea della penisola fu completata solo nel 553. Il conflitto si protrasse quindi per quasi un ventennio, devastando l’intera Italia tanto da portarla a una grave crisi demografica, economica, politica e sociale. I sovrani ostrogoti che si succedettero al comando (Teodato, Vitige, Totila, Teia), forti anche del sostegno fornito dai vicini Franchi e Burgundi, altri Germani stanziati in Gallia (l’odierna Francia), riuscirono a resistere a lungo agli attacchi dei Bizantini, a lro volta indeboliti da una rivalità tra i due comandanti, Belisario e Narsete.
La definitiva sconfitta degli Ostrogoti nella Battaglia dei Monti Lattari, dove Narsete piegò Teia, portò l’intera Italia sotto la sovranità bizantina, ma gli anni seguenti furono funestati, oltre che da un aggravamento delle condizioni di vita dei contadini a causa della forte pressione fiscale, anche da una terribile pestilenza che spopolò ulteriormente la penisola (559-562).
Inizio medioevo
L’Italia bizantina, indebolita e impoverita, non ebbe la forza di opporsi a una nuova invasione germanica, quella dei Longobardi capeggiati da Alboino. Tra il 568 e il 569 i Longobardi, che trovarono spesso appoggio tra la popolazione esasperata dalla fiscalità bizantina, occuparono gran parte dell’Italia centro-settentrionale. Questa regione, che da allora sarebbe stata detta Langobardia Major (“Langobardia Maggiore”), costituì il nucleo del Regno longobardo, con capitale Pavia, ma contingenti germanici si spinsero anche nell’Italia meridionale, dove costituirono i ducati della Langobardia Minor (“Langobardia Minore”): Spoleto e Benevento. L’intero Regno longobardo fu infatti ripartito in numerosi ducati, ampiamente autonomi rispetto al potere centrale.
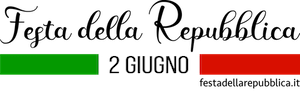



Lascia un commento