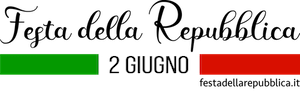Il popolamento del territorio italiano risale alla preistoria, epoca di cui sono state ritrovate importanti testimonianze archeologiche. L’Italia è stata abitata almeno a partire dal periodo Paleolitico.
Preistoria e la nascita di Roma – Tra i più interessanti siti archeologici italiani risalenti al paleolitico, si ricorda quello di Monte Poggiolo, presso Forlì e la Grotta dell’Addaura, presso Palermo, nella quale si trova un vasto e ricco complesso da incisioni, databili fra l’Epigravettiano finale e il Mesolitico, raffiguranti uomini ed animali.Tra i popoli insediatisi nel Neolitico, quando l’uomo da cacciatore divenne anche anche pastore e agricoltore, si ricordano gli antichi Camuni (in Val Camonica).Le informazioni sulle genti abitanti la penisola in epoca preromana sono, in taluni casi, incomplete e soggette a revisione continua.

Popolazioni di ceppo indoeuropeo, trasferitesi in Italia dall’Europa Orientale e Centrale in varie ondate migratorie (veneti, umbro-sabelli, latini, ecc.), si sovrapposero ad etnie pre-indoeuropee già presenti nell’attuale territorio italiano, o assorbendole, oppure stabilendo una forma di convivenza pacifica con esse. Secondo alcune fonti, la loro provenienza andrebbe ricercata in Asia Minore, secondo altre, avrebbero costituito una etnia autoctona. Certo è che, già attorno alla metà del VI secolo a.C., riuscirono a creare una forte ed evoluta federazione di città -stato che andava dalla Pianura Padana alla Campania e che comprendeva anche Roma ed il suo territorio.
In Italia settentrionale, accanto ai Celti (comunemente chiamati Galli), vi erano i Liguri (originariamente non indoeuropei poi fusisi con i Celti) stanziati in Liguria e parte del Piemonte mentre nell’Italia nord-orientale vivevano i Veneti (paleoveneti) di probabile origine illirica o, secondo alcune fonti, provenienti dall’Asia Minore.
Nell’Italia più propriamente peninsulare accanto agli Etruschi, convivevano tutta una serie di popoli, in massima parte di origine indoeuropea, fra cui: Umbri in Umbria; Latini, Sabini, Falisci, Volsci ed Equi nel Lazio; Piceni nelle Marche ed in Abruzzo Settentrionale; Sanniti nell’Abruzzo Meridionale, Molise e Campania; Apuli, Messapi e Iapigi in Puglia; Lucani e Bruttii nell’estremo Sud; Siculi, Elimi e Sicani (non indoeuropei, probabilmente autoctoni) in Sicilia.
La Sardegna era abitata, fin dal II millennio a.C., dai Sardi, risultato, forse, di un connubio tra le preesistenti popolazioni megalitiche presenti nell’Isola ed il misterioso popolo dei Shardana.Nell’area laziale, invece, un posto a se stante meritano i Latini protagonisti, assieme ai Sabini, della primitiva espansione dell’Urbe e forgiatori, insieme agli Etruschi ed ai popoli italici più progrediti (Umbri, Falisci, ecc.), della futura civiltà romana.
Primi stanziamenti Fenici nell’attuale territorio italiano sono datati attorno all’VIII secolo a.C. quando, dopo una iniziale fase di precolonizzazione del Mediterraneo occidentale e di fondazione di città come Utica e Cartagine, veri e propri colonizzatori si insediarono sulle coste della Sardegna e nell’area occidentale della Sicilia. Nascono Mozia (da cui più tardi Lilibeo), Palermo, Solunto in Sicilia e Sulci, Nora, Tharros, Bithia, Cagliari in Sardegna.
Mentre in Sicilia l’installazione fenicia non incontra grandi reazioni da parte degli autoctoni (a Monte Erice, per esempio, un tempio fu dedicato ad Astarte, dea-madre dell’area cananea, che veniva frequentato dai Fenici e dagli Elimi), in Sardegna i Fenici, per la decisa resistenza che incontrarono, non riuscirono controllare territori molto ampi lontano dalle loro città .A metà del VI secolo, con la spedizione del semileggendario Malco iniziò il tentativo di conquista, vera e propria delle isole maggiori.
Cartagine, a tre secoli dalla fondazione, aveva raggiunto i limiti di espansione lungo la costa settentrionale dell’Africa dove, a est aveva fermato la colonizzazione greca vincendo gli scontri con Cirene e verso ovest intratteneva ottimi rapporti con Numidi e Mauri. Le coste della Spagna erano ben controllate, Gli Etruschi non impensierivano i punici. Solo la Sicilia vedeva la costante migrazione e i continui insediamenti delle popolazioni della Grecia che lentamente ma sicuramente spinsero i Fenici nell’estrema punta occidentale dell’isola.Questa pressione demografica e -soprattutto- economica spinse Cartagine al tentativo di fermare i Greci o addirittura di conquistare l’intera Sicilia.
Ciò avrebbe consentito il totale controllo dei due passaggi dal Mediterraneo Orientale a quello Occidentale. Una serie di interventi bellici nell’arco di due secoli (dal 550 a.C. al 275 a.C.) non portarono a grandi risultati. A fasi alterne le varie guerre greco-puniche allargarono la sfera di influenza cartaginese o greca in Sicilia senza che nessuno dei due popoli riuscisse a prevalere nettamente sull’altro. Tutto si concluse con lo scoppio della prima guerra punica che tolse ai Cartaginesi le aree siciliane e pose una pesante ipoteca su Siracusa, unico regno siceliota di qualche importanza.Cartagine riuscì¬ comunque a bloccare quasi completamente l’espansione greca nel Mediterraneo occidentale; dai greci furono inizialmente fondate solo Marsiglia, Alalia e Cuma; altre colonie sorsero più tardi.
Per contro, in Sardegna, l’espansione cartaginese incontra maggiori difficoltà per la resistenza offerta da parte delle fiere popolazione autoctone. Ciononostante, già intorno al 450 a.C., i Cartaginesi erano riusciti ad organizzare nell’isola un sistema abbastanza stabile di frontiere interne, sempre all’interno della loro politica imperialista nel contesto mediterraneo. Lo sforzo bellico in Sardegna riuscì a rendere l’isola un vero e proprio possedimento, come il territorio della costa libica, dove l’imperio Cartaginese poté dirigere la produzione mineraria e agricola in relazione alle necessità puniche e non solo autoctone.
Nel corso del tempo i Cartaginesi giunsero quindi a chiudere le coste dell’isola in un vero e proprio cerchio di fortezze e colonie. L’agricoltura sarda, era dedicata principalmente alla produzione di grano tanto che già nel 480 a.C. Amilcare, impegnato nella battaglia di Imera, fece venire dalla Sardegna in Sicilia i rifornimenti di grano per le sue truppe.
Dallo pseudo-aristotelico De mirabilibus auscultationibus sappiamo che Cartagine proibiva la coltivazione di piante da frutto per spingere la monocultura del grano. L’artigianato sardo era fortemente condizionato dagli stili artistici e dalle commesse che i cartaginesi portavano nell’isola.Cartagine entrò anche nella storia d’Italia peninsulare riuscendo ad allearsi con gli Etruschi per combattere i greci di Alalia, in Corsica, che si erano dati alla pirateria.
Preistoria e la nascita di Roma
Le Lamine di Pyrgi ci mostrano quanto fosse sentito l’influsso cartaginese sulle coste toscane e laziali. àˆ del 509 a.C., infine, l’inizio di relazioni diplomatiche importanti fra Cartagine e Roma. La neonata Repubblica romana e i cartaginesi siglarono il primo dei Trattati Roma-Cartagine, il primo riconoscimento che Cartagine offrì a Roma e che segnò l’inizio di stabili relazioni fra le due città . Altri trattati vennero, nel tempo, conclusi; la loro formulazione segue, nell’ampliarsi e restringersi delle concessioni dei Cartaginesi ai Romani, l’alternarsi dell’evoluzione territoriale e di potenza dell’Urbe.
Tra l’VIII ed il VII secolo a.C., coloni provenienti dalla Grecia cominciarono a stabilirsi sulle coste del sud Italia e della Sicilia. Le prime componenti stabilitesi in Italia furono quella ioniche e quelle peloponnesiache: gli Eubei e i Rodii fondarono Cuma, Reggio Calabria, Napoli, Naxos e Messina, i Corinzi Siracusa, i Megaresi Leontinoi, gli Spartani Taranto, mentre i coloni provenienti dall’Acaia e fondarono Sibari e Crotone. Oltre a quelle sopra menzionate, altre importanti furono Metaponto, fondata anch’essa da coloni Achei, Heraclea e Locri Epizefiri.
L’importanza della colonizzazione greca per i popoli italici è dovuta al fatto che essi vennero così a contatto con forme di governo democratiche caratterizzate da forti responsabilizzazioni del cittadino, e con espressioni artistiche e culturali elevate; basti pensare ai filosofi e uomini di scienza dell’epoca, fra cui Pitagora ed Archimede, nati in Italia, ma di cultura greca.
Preistoria e la nascita di Roma – I contrasti fra le colonie greche e gli indigeni furono frequenti, tuttavia i Greci cercarono di instaurare rapporti pacifici con le popolazioni locali, favorendo, in molti casi, un lento assorbimento delle stesse. La ricchezza e lo splendore delle colonie furono tali da far identificare l’Italia meridionale dagli storici romani con l’appellativo di Magna Grecia. Nel III secolo a.C. tutte le colonie italiote e siciliane furono assorbite nello Stato romano. Per molte di esse iniziò un fatale declino.